La maledizione della conoscenza
La maledizione della conoscenza crea un falso senso di chiarezza nella comunicazione: la nostra stessa competenza può impedirci di riconoscere l'ambiguità percepita dagli altri.
Benvenute a tutte le nuove persone iscritte! Da questo numero c’è una novità: ho attivato la possibilità di abbonarsi ad Alternate Takes. Se apprezzi quello che scrivo è un modo per sostenere il mio lavoro. Cosa cambia? Niente. Non ho attivato un paywall per l’archivio dei post, che rimane aperto a tutti; non ho progettato contenuti in esclusiva per chi si abbona, almeno per ora. Lascio al tuo buon cuore e alle tue possibilità, insomma.
Fino alla fine di aprile è anche attivo uno sconto. O almeno dovrebbe, chissà se ci ho capito qualcosa, tra tutte le impostazioni: se non funziona scrivimi. Se decidi di abbonarti ti ringrazio. In ogni caso, ci leggiamo sotto.
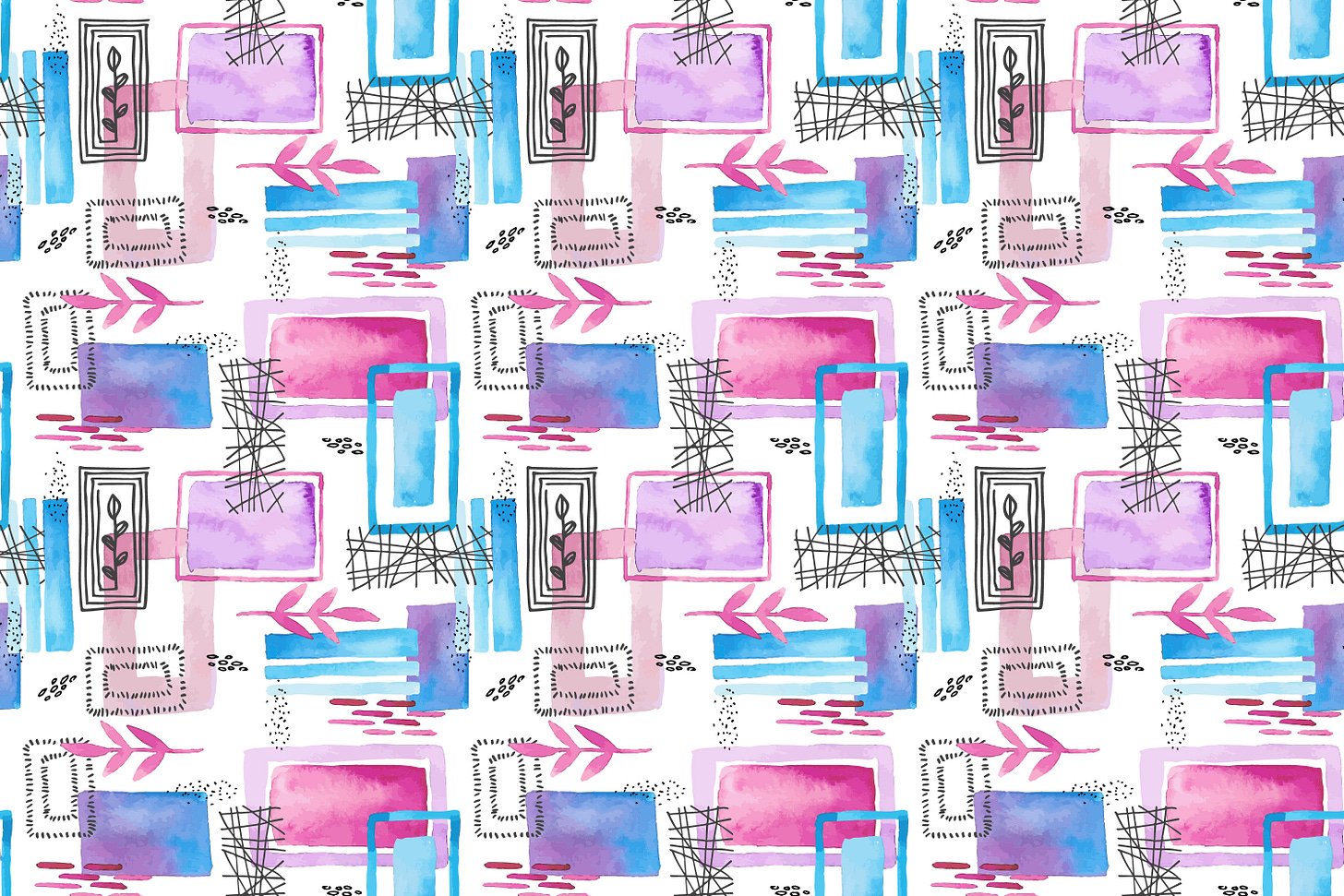
Sulle parole: quelle che ci sembrano scontate
Ti è mai capitato di pensare «ah, ho spiegato la cosa in modo chiaro!» per scoprire invece che chi ascoltava non ha capito un granché? Potrebbe averti risposto dicendo «ora rispiegamelo come faresti con un bambino di cinque anni», e ti starebbe dando un’ottima dritta. È la maledizione della conoscenza (in inglese Curse of knowledge), un bias cognitivo che ci porta a presumere che gli altri condividano il nostro stesso livello di sapere1.
La maledizione della conoscenza ci fa credere che la comprensione di termini specifici, concetti complessi o informazioni di base siano patrimonio comune, ma ci sbagliamo. Una volta acquisita una conoscenza, diventa difficile immaginare di non possederla: questa consapevolezza è la nostra maledizione, che ci rende difficile trasmettere ad altri il nostro sapere, perché non riusciamo facilmente a ricreare lo stato mentale di chi ascolta.
Le persone esperte tendono a dimenticare com’è non avere le strutture cognitive altamente organizzate che hanno acquisito nel loro campo: sono queste che consentono loro di elaborare e archiviare le informazioni in modo efficiente. Dimenticando cosa significa non possedere questi schemi, possono sorvolare su informazioni cruciali per la comprensione di una persona alle prime armi.
È come se la conoscenza acquisita avesse una particolare tenacia: una volta integrata nel nostro sistema cognitivo diviene la prospettiva predefinita, oscurando la nostra capacità di adottare un punto di vista da principiante. Il nostro cervello è predisposto ad apprendere e memorizzare informazioni: un’efficienza che si trasforma in un ostacolo quando dobbiamo condividere questa conoscenza con altri che non hanno seguito lo stesso percorso. Perdiamo la capacità di accedere facilmente alla “mente del principiante”.
La maledizione in azione
La maledizione della conoscenza si manifesta in diversi contesti e crea barriere alla comunicazione e all’apprendimento.
Nella comunicazione interpersonale, un esempio è l’uso di linguaggio specialistico, acronimi e termini tecnici senza fornire spiegazioni. All’interno di una comunità di esperti il linguaggio specialistico rappresenta una scorciatoia comunicativa efficiente, ma quando ci si rivolge a un pubblico più ampio, questa efficienza si trasforma in un impedimento, escludendo coloro che non hanno acquisito gli stessi riferimenti linguistici.
Nella scrittura, la maledizione della conoscenza può insidiare la chiarezza. Chi scrive di argomenti che conosce a fondo potrebbe non rendersi conto di non aver spiegato concetti fondamentali, o saltato passaggi e azioni che considera ovvi. Steven Pinker, nel suo libro The Sense of Style, afferma che la maledizione della conoscenza è la migliore spiegazione del perché persone intelligenti scrivano male. Il monologo interiore di chi scrive e la sua profonda comprensione dell’argomento possono creare un punto cieco e rendere difficile capire quali informazioni servono a chi legge per seguire il filo del discorso.
Nel content design, la maledizione della conoscenza può portare alla creazione di interfacce intuitive solo per chi le ha progettate. In questo campo, la maledizione della conoscenza può portare a prodotti e servizi inutilizzabili o frustranti per il pubblico di riferimento. I designer che hanno familiarità con la logica del sistema, potrebbero non rendersi conto del carico cognitivo che impongono ai nuovi utenti.
Anche nell’insegnamento, la maledizione della conoscenza rappresenta una sfida significativa. Un insegnante potrebbe non ricordare più le difficoltà che uno studente alle prime armi incontra nell’apprendere una nuova materia, o sottovalutare il tempo necessario ai principianti per apprendere determinate competenze.
La maledizione della conoscenza crea un falso senso di chiarezza nella comunicazione: la nostra stessa competenza può impedirci di riconoscere l'ambiguità percepita dagli altri.
La trappola dell’esperto
Torniamo a Steven Pinker, perché ha dedicato grande attenzione al modo in cui la maledizione della conoscenza si manifesta nell'uso del linguaggio, specialmente in contesti accademici ed esperti. Secondo Pinker, diversi problemi riscontrabili nell’inglese usato in ambito accademico sono strettamente correlati a questo bias cognitivo.
Pinker sostiene che gli autori esperti spesso presumono che i lettori abbiano già acquisito il loro linguaggio specialistico, conoscano i passaggi intermedi che a loro appaiono ovvi e siano in grado di visualizzare mentalmente le scene che l’autore ha in mente. Questa presunzione li porta a non preoccuparsi di spiegare termini tecnici, esplicitare la logica del loro ragionamento o fornire dettagli concreti, anche quando si rivolgono a colleghi di altre discipline.
Pinker analizza diverse manifestazioni linguistiche specifiche della maledizione della conoscenza.
L'uso di un linguaggio astratto. L'astrazione può rendere difficile per i lettori collegare i concetti a esempi concreti del mondo reale, ostacolando la comprensione, specialmente per chi si avvicina all’argomento per la prima volta. Un linguaggio concreto, al contrario, radica le idee in esperienze tangibili, rendendole più facili da visualizzare e comprendere. Il linguaggio astratto, invece, rimane nel regno dei concetti, richiedendo uno sforzo cognitivo maggiore per essere elaborato.
Le transizioni poco fluide tra argomenti correlati. Transizioni inadeguate presumono che il lettore sia in grado di seguire intuitivamente il flusso logico tra le idee, cosa che potrebbe non verificarsi per chi ha una familiarità minore con l’argomento. Transizioni chiare agiscono come segnali stradali per il lettore, guidandolo attraverso l’argomentazione e assicurando che comprenda come i diversi punti si collegano tra loro.
Le nominalizzazioni (zombie nouns). Trasformare i verbi in sostantivi può rendere la scrittura più passiva e meno diretta, oscurando il soggetto dell’azione e rendendo le frasi più difficili da interpretare. La voce attiva con verbi chiari tende a essere più coinvolgente e facile da comprendere rispetto a costruzioni passive con sostantivi astratti.
L’uso eccessivo di espressioni di cautela (hedging). Nonostante gli accademici possano ricorrere a espressioni come “in un certo senso”, “relativamente” e “fino a un certo punto” per comunicare sfumature ed evitare affermazioni categoriche, il loro uso può rendere la scrittura incerta e meno autorevole, confondendo il lettore riguardo al messaggio principale. È necessario un equilibrio tra la trasmissione di una cautela appropriata e la presentazione di informazioni in modo chiaro e sicuro.
Pinker propone una scrittura caratterizzata da un approccio descrittivo e colloquiale, con l’obiettivo primario di aiutare il lettore a “vedere la realtà” attraverso le parole. Raccomanda di privilegiare la chiarezza rispetto alla dimostrazione di intelletto e suggerisce di presumere che i lettori siano intelligenti ma meno informati sull’argomento trattato.
La soluzione di Pinker alla maledizione della conoscenza nella scrittura implica un cambiamento di prospettiva, spostando l’attenzione dalla conoscenza interna di chi scrive all’esperienza di chi legge. Questo richiede uno sforzo consapevole per rendere la scrittura più accessibile e coinvolgente. Una comunicazione efficace pone la comprensione del pubblico al primo posto, adottando uno stile che anticipi le sue esigenze e lo guidi attraverso le informazioni in modo chiaro e convincente.
Come spezzare la maledizione
Abbiamo a disposizione diverse strategie pratiche che possono essere antidoti alla maledizione della conoscenza.
Comprendere il proprio pubblico. Ciò significa valutare il livello di conoscenza di base sull’argomento, considerare cosa potrebbero sapere e cosa invece ignorare. È un passo cruciale, perché richiede un atto di empatia e uno sforzo consapevole per uscire dalla propria cornice di riferimento. Prima di iniziare a scrivere o progettare contenuti, è essenziale porsi delle domande: a chi mi sto rivolgendo? Cosa sa già? Quali sono i suoi bisogni e le sue aspettative?
Usare un linguaggio semplice e chiaro. Evitiamo gergo, termini tecnici o acronimi oscuri e preferiamo un linguaggio piano e diretto. Se l’uso di termini tecnici è inevitabile, spieghiamo il significato; traduciamo concetti complessi in un linguaggio di tutti i giorni. La chiarezza è fondamentale: l'uso di un linguaggio accessibile garantisce che il messaggio raggiunga e risuoni con il pubblico di riferimento, indipendentemente dal suo livello di competenza.
Usare esempi concreti, analogie e storytelling. Le analogie semplificano argomenti complessi, mentre gli esempi rendono concreti i concetti astratti. Le storie, infine, rendono le informazioni più coinvolgenti e memorabili. I concetti astratti diventano più comprensibili e interessanti quando li illustriamo con esempi concreti, analogie pertinenti o narrazioni avvincenti. Queste tecniche colmano il divario tra la conoscenza dell'esperto e la comprensione del principiante. Il cervello umano è predisposto per le storie e gli esempi, che forniscono contesto e rendono le informazioni più tangibili, favorendo la comprensione e la memorizzazione.
Richiedere feedback e testare i propri contenuti. Mostrare bozze iniziali a un lettore rappresentativo del proprio pubblico o testare la propria scrittura su persone con un background simile a quello del pubblico di riferimento può rivelare punti poco chiari o incomprensibili. Nel caso del content design, effettuare test con gli utenti è fondamentale per verificare l'usabilità e la comprensione delle interfacce. Il feedback del pubblico di riferimento è preziosissimo per identificare i casi in cui la maledizione della conoscenza si è insinuata nella comunicazione. Testare i contenuti con utenti rappresentativi fornisce indicazioni dirette su ciò che è chiaro e ciò che invece crea confusione. La nostra stessa comprensione può renderci ciechi a potenziali punti di confusione per gli altri, e cercare prospettive esterne aiuta a scoprire questi punti ciechi e a perfezionare la comunicazione.
Abbracciare la “mente del principiante”. Dobbiamo sforzarci di considerare l’argomento come se lo vedessimo per la prima volta, cercando di dimenticare ciò che sappiamo e di guardarlo con occhi nuovi. Lo sforzo consapevole di vedere l’argomento con ingenuità ci permette di identificare meglio i concetti fondamentali che necessitano di spiegazione ed evitare di fare supposizioni sulla conoscenza pregressa.
Il ponte dell’empatia
L'empatia cognitiva, ovvero la capacità di assumere la prospettiva di un’altra persona senza imporre i propri pregiudizi, si rivela uno strumento prezioso per superare le lacune empatiche determinate dalla maledizione della conoscenza. L’empatia implica la comprensione dello stato emotivo delle persone e la progettazione di contenuti che rispondano alle loro esigenze.
Quando scrittori e content designer danno priorità alla comprensione della prospettiva del proprio pubblico, riescono a creare contenuti non solo informativi ma anche in sintonia con i bisogni e le aspettative delle persone, portando a un maggiore coinvolgimento e a una migliore comprensione. Contenuti progettati con empatia anticipano le domande dell’utente, affrontano le sue preoccupazioni e lo guidano attraverso le informazioni in modo naturale e intuitivo.
Esistono diverse tecniche per mettere in primo piano la prospettiva dell’altro.
Ricerche sugli utenti ed empathy map sono strumenti fondamentali per comprendere i bisogni e le motivazioni delle persone.
L’ascolto attivo e non dare nulla per scontato, ponendo invece domande chiarificatrici, sono approcci che aiutano a svelare il punto di vista dell’altro.
È utile anche considerare l'ambiente e le pressioni che il nostro pubblico potrebbe affrontare e cercare di identificare le motivazioni che guidano le loro azioni.
Impegnarsi attivamente per conoscere il background, le esperienze e i punti di vista del pubblico ci permette di liberarci dalle nostre supposizioni e di comunicare in modo da creare una vera connessione.
Leggi anche
» Chuck Leddy, Exorcising the curse of knowledge, The Harvard Gazette (2012)
» Chip Heath, Dan Heath, The Curse of Knowledge, Harvard Business Review (2006)
» Ivo Herka, The curse of knowledge, (2019)
Vuoi lavorare con me?
Esercizi
Scegli un termine tecnico del settore in cui hai più esperienza e scrivi due definizioni: una per i tuoi pari e una per persone completamente estranee all’argomento. Com’è andata?
Acchiappa2 un bambino o una bambina di cinque, sei anni al massimo e prova a spiegargli che cos’è il tempo che passa. Poi torna qui e dimmi come hai fatto il miracolo.
Spiega a tuo padre, tua nonna, tuo zio, come connettere la stampante al computer. Dopo la terza spiegazione infruttuosa, prova a capire cosa non sta funzionando e come potresti semplificarlo.

Un libro
Chiamo il nostro mondo Flatlandia, non perché sia così che lo chiamiamo noi, ma per renderne più chiara la natura a voi, o Lettori beati, che avete la fortuna di abitare nello Spazio.
Immaginate un vasto foglio di carta su cui delle Linee Rette, dei Triangoli, dei Quadrati, dei Pentagoni, degli Esagoni e altre Figure geometriche, invece di restar ferme al loro posto, si muovano qua e là, liberamente, sulla superficie o dentro di essa, ma senza potersene sollevare e senza potervisi immergere, come delle ombre, insomma – consistenti, però, e dai contorni luminosi. Così facendo avrete un’idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti.
Flatlandia, Edwin A. Abbott
Qualcosa di utile
Non lavoro più in ufficio da un bel po’ di anni, ma non mollo il mio portapranzo definitivo, quello che non mi ha mai tradito aprendosi a casaccio o lasciando colare i condimenti: i monbento, sarebbe a dire bentō (giapponesi) ma fatti dai francesi. Lo so, lo so, non si fa: ma i giapponesi mangiano poco, mi sa, e con i loro formati mi rimaneva la fame.
Quindi ecco, se hai bisogno di qualcosa di più affidabile di un tupperware per un pranzo al sacco, dalla pausa in ufficio a una più godibile giornata in piscina, ti propongo la versione fame normale e la versione fame da lupi (ma occhio, che di lupi con questa ne sfami due o tre). Buon appetito.
Tre link
The Unbelievable Scale of AI’s Pirated-Books Problem. Meta pirated millions of books to train its AI. Su The Atlantic puoi anche levarti lo sfizio di verificare quali.
Empowering Information Architecture with AI: Making It Real. An approach to using AI to re-categorize content in a 1,200-page website.
Transactional vs. Conversational Visions of Generative AI in Teaching. AI as a Printer, or AI as a Thought Partner.
In ascolto
Se usi Spotify puoi salvare la playlist.
Potresti voler leggere anche
Note
Potrebbe interessarti l’origine del termine, coniato nel 1989 dagli economisti Camerer, Loewenstein e Weber, in un articolo del Journal of Political Economy: lo scopo della loro ricerca era quello di contrastare le “comuni assunzioni in tali analisi (economiche) sul fatto che agenti meglio informati possono anticipare con precisione il giudizio di agenti meno informati”. [Wikipedia]
Acchiappa bambini che hai diritto di acchiappare, e fallo con buone maniere, cerchiamo di non finire in galera.

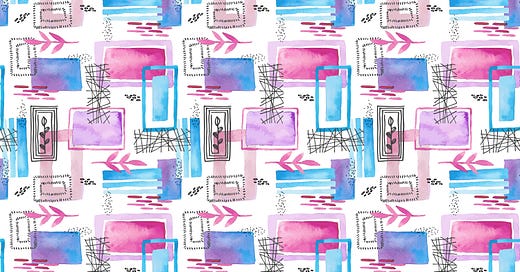


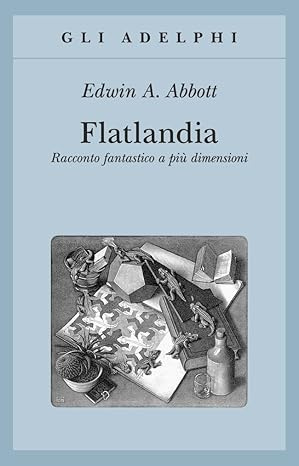




Questo articolo me lo incornicio. E mi verrebbe da mandarlo a un po' di gente... che però non so se lo prenderebbe bene! 🙈 Perché spesso chi sa tanto è anche molto, molto sensibile. 😹
Molto interessante grazie! In effetti sto proprio in questo momento supportando un gruppo scientifico di medici nella scrittura di storie partendo dai casi clinici. E la vera difficoltà sta nello scrivere la storia spogliandola dalla scienza, dalla biologia, recuperando la parte umana, tirando fuori le emozioni e i valori che quella vita (non più caso clinico) è in grado di generare…
Mi sono resa conto che non è per niente semplice de-costruire un concetto, liberarsi di infrastrutture e ri-comunicarlo in “parole semplici”. Certo lo è per me che appartengo ad altri mondi e non a quello della scienza e in questo senso la scrittura, l’arte, la musica, le “humanities” in generale sono un forte strumento per annullare questa maledizione e facilitano la costruzione di “ponti” di senso per una comunicazione accessibile e inclusiva…