Il suono delle parole
L'attenzione al suono delle parole è una potente strategia comunicativa, capace di rendere l'informazione un'esperienza sensoriale.
Menomale che fate attenzione voi, perché nello scorso numero di Alternate Takes ho fatto due errori belli sonori.
Anna Aresi mi ha segnalato che il libro di Dr. Seuss che usa 50 parole non è The Cat in the Hat, ma Green Eggs and Ham (prosciutto e uova verdi, in italiano, che probabilmente avevo mangiato, per rimbambirmi così).
Samuele Parravicini invece ha trovato il link sbagliato per le risorse per insegnare la cultura della progettazione di Designers Italia.
Grazie a entrambi per avermi dato modo di correggere le sviste.
Segnalo poi che:
con
siamo stati a WIAD 2025 a Roma. Il nostro intervento era “Il giardino dei contenuti che si biforcano. Contenuti modulari ed evoluzione continua”: non è disponibile un video, ma ci sono le slide;la prossima edizione del Festival DiParola sarà il 19 e 20 settembre 2025 ad Ancona: è già possibile sostenere l’evento e riservare il proprio posto (o offrirne uno sospeso).
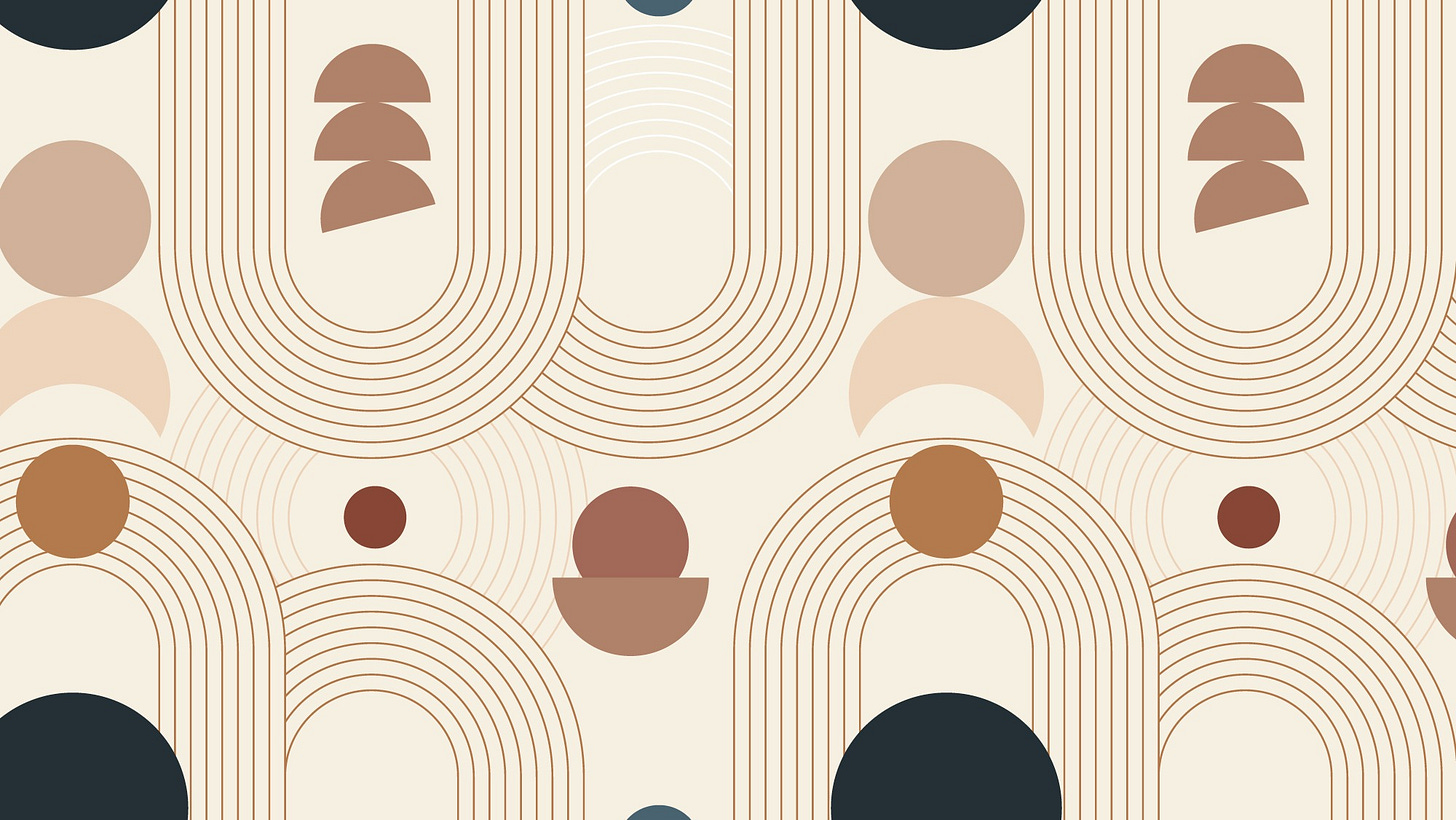
Sulle parole: dal suono al vocabolario
Sdeng! Thud.
Se leggi Topolino sai cosa è successo nella riga precedente: qualcuno ha sbattuto, probabilmente contro qualcosa di metallico, ed è cascato a terra con un rumore sordo1. “Sdeng” e “thud” sono onomatopee: sequenze di suoni che cercano di riprodurre o evocare un suono naturale.
Può trattarsi di una successione di suoni (brrr, crac, miao, drin), di una serie di sillabe (patatrac, coccodè) o possono addirittura diventare una parte autonoma del discorso, trasformandosi in un nome o in un verbo: il ticchettio dell’orologio, il gracidare delle rane, il miagolio del gatto.
Le onomatopee fanno pensare subito ai fumetti, se li abbiamo letti: sono quasi una colonna sonora che accompagna le scene rappresentate. In diversi casi si tratta di onomatopee apparenti: nei fumetti Disney, per esempio, non sono altro che voci inglesi (to thud, fare un rumore sordo; to sob, singhiozzare; to mumble, borbottare) che, ereditate dai fumetti di produzione italiana, abbiamo tutti pronunciato così come sono scritte.
Interpretazioni culturali del suono
Nonostante tentino di riprodurre suoni universali, ogni lingua interpreta le onomatopee in modo diverso. Il verso del gallo, per esempio, è “chicchirichì” in italiano, “cock-a-doodle-doo” in inglese, “kikeriki” in tedesco e “cocorico” in francese. Le onomatopee non sono copie perfette dei suoni naturali, ma trascrizioni filtrate attraverso i sistemi linguistici.
Apprendere le onomatopee di una lingua straniera può essere sorprendentemente difficile, proprio perché riflettono modi culturalmente specifici di sentire e categorizzare i suoni. Questo fenomeno è evidente quando si confrontano lingue di famiglie molto diverse. Per esempio, le onomatopee giapponesi spesso risultano incomprensibili per parlanti occidentali, e viceversa, nonostante tentino di rappresentare gli stessi suoni naturali.
La parola onomatopea esprime fin dalla sua etimologia il potere della lingua di creare nuove parole imitando o suggerendo suoni2 : alcune si adattano fino a entrare stabilmente nel lessico della lingua. Bisbigliare, tentennare, miagolare non sono più onomatopee, ma parole di origine onomatopeica.
Suoni e significati
Le onomatopee rientrano nel campo più ampio del fonosimbolismo: nonostante oggi si consideri in linea di massima arbitraria la natura dei segni linguistici (in altre parole: diciamo “gatto” senza un particolare motivo che leghi il suono della parola al simpatico felino), c’è comunque attenzione verso gli aspetti fonosimbolici delle lingue. Il fonosimbolismo può rivelarci relazioni tra suoni e sensazioni.
Le vocali alte e anteriori come /i/ suggeriscono piccole dimensioni e suoni acuti (“piccino”, “minuscolo”).
Le vocali basse e posteriori come /o/ e /a/ evocano grandezza e suoni gravi (“grande”, “vasto”).
Le consonanti occlusive (/p/, /t/, /k/) richiamano interruzioni nette, colpi secchi.
Le fricative (/f/, /s/, /ʃ/) creano sensazioni di continuità, fluidità o frizione.
La /r/ suggerisce ruvidità, vibrazione, rotolamento.
La /l/ evoca fluidità, scorrevolezza.
Poeti e pubblicitari, se mi perdonate l’accostamento, comprendono più di altri che il suono delle parole può comunicare messaggi che vanno oltre il loro significato letterale, creando associazioni emotive e sensoriali potenti e spesso inconsapevoli nel lettore o consumatore.
La dimensione sonora nelle scritture non creative
La ricchezza lessicale legata ai suoni diventa uno strumento di immersione: il sussurro di una confidenza, il boato di una folla, il fruscio delle foglie, il crepitio del fuoco. Ogni termine non solo descrive un suono ma porta con sé un’atmosfera, un contesto emotivo, trasformando l’informazione in esperienza.
Per chi scrive non-fiction, dalle guide di viaggio ai reportage giornalistici, dalle descrizioni scientifiche ai podcast, le onomatopee e i termini di origine onomatopeica rappresentano non semplici abbellimenti stilistici, ma potenti strumenti per creare una sorta di realtà aumentata verbale, dove l’informazione viene percepita attraverso molteplici canali sensoriali, anche quando è trasmessa solo attraverso le parole.
Parole che suonano: il caso dei podcast
In un podcast sulla natura, parlare del “rumore dell'acqua” o del "gorgoglio del ruscello che scorre tra i sassi” crea due esperienze completamente diverse. La prima espone un fatto; la seconda trasporta l'ascoltatore sul posto, attivando la memoria sonora.
La selezione delle parole nei podcast di non fiction non risponde solo a criteri di precisione informativa, ma anche a necessità di evocazione sensoriale. La scelta di parole con determinate qualità fonetiche influenza il ritmo e la melodia del discorso. I termini ricchi di consonanti occlusive (/p/, /t/, /k/) creano pause naturali e rendono il ritmo più scandito, ideale per sottolineare punti chiave. Al contrario, parole con molte fricative (/f/, /s/, /v/) e liquide (/l/, /r/) permettono una narrazione più fluida e scorrevole.
Questo diventa evidente nei podcast divulgativi, in cui è necessario alternare momenti di tensione cognitiva (presentazione di concetti complessi) a momenti di rilassamento (spiegazioni, esempi, aneddoti). La scelta consapevole di parole con qualità sonore diverse è una delle leve che permette al narratore di modulare questa tensione.
Nei podcast, la dimensione sonora del linguaggio si fonde con l’uso di effetti sonori e musica. La scrittura efficace anticipa questa interazione:
Parole-ponte: termini che anticipano o richiamano un effetto sonoro che seguirà o che è appena stato ascoltato. Per esempio, prima di inserire il suono di una tempesta, utilizzare parole come “scrosciare”, “tuonare”, prepara l'orecchio dell'ascoltatore.
Contrappunto verbale: utilizzare parole dal profilo sonoro contrastante rispetto agli effetti di sottofondo, per evidenziare determinati concetti e renderli più distinguibili.
Sincronizzazione ritmica: adattare il ritmo naturale delle frasi al ritmo della musica di sottofondo, creando punti di sincronizzazione che rafforzano emotivamente i momenti chiave.
La dimensione sonora del linguaggio nei podcast non è solo una questione estetica, ma ha importanti implicazioni cognitive. Il ritmo, le allitterazioni e le associazioni fonosimboliche funzionano come ganci mnemonici, e ci aiutano a ricordare le informazioni che presentano. Il suono delle parole attiva aree cerebrali legate all’elaborazione emotiva, creando un coinvolgimento più profondo rispetto alla semplice trasmissione di informazioni.
Scrivere per podcast significa comporre una partitura verbale dove ogni parola è scelta non solo per il suo significato ma anche per il suo contributo al paesaggio sonoro complessivo. L’attenzione alla dimensione acustica del linguaggio trasforma l’informazione in esperienza, il dato in narrazione, costruendo un ponte multisensoriale tra il narratore e l’ascoltatore che arricchisce profondamente la comunicazione dei contenuti fattuali.
Parole che suonano bene
L’attenzione al suono delle parole è una potente strategia comunicativa, capace di rendere l’informazione un’esperienza sensoriale. Questa cura per l’aspetto sonoro non è esclusiva della narrazione orale o creativa, ma è radicata nella lingua. Gli echi dei suoni originari nel nostro vocabolario testimoniano il ruolo del suono nella creazione ed evoluzione del linguaggio, e continuano a plasmare la nostra percezione e descrizione del mondo.
Vuoi lavorare con me?
Esercizi
Non gridate più
Cessate d’uccidere i morti,
Non gridate più, non gridate
Se li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.
Hanno l’impercettibile sussurro,
Non fanno più rumore
Del crescere dell’erba,
Lieta dove non passa l’uomo.
Giuseppe Ungaretti. Ascolta il suono della sua lettura su Rai Teche.
Ascolta come Fabrizio De André canta e pronuncia il testo di Dolcenera.
Un libro
Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città, e rimbombava incessante, ossessivo, spazzando qualsiasi altro suono, scandendo la grande menzogna. Zì, zì, zì! Vive, vive, vive! Un ruggito che non aveva nulla di umano. Infatti non si alzava da esseri umani, creature con due braccia e due gambe e un pensiero proprio, si alzava da una bestia mostruosa e senza pensiero, la folla, la piovra che a mezzogiorno, incrostata di pugni chiusi, di volti distorti, di bocche contratte, aveva invaso la piazza della cattedrale ortodossa poi allungato i tentacoli nelle strade adiacenti intasandole, sommergendole con l'implacabilità della lava che nel suo straripare divora ogni ostacolo, assordandole con il suo zì, zì, zì. Sottrarsene era illusione. Alcuni tentavano, e si chiudevano nelle case, nei negozi, negli uffici, ovunque sembrasse di trovare un riparo, non udire almeno il ruggito, ma filtrando attraverso le porte, le finestre, i muri, esso gli giungeva ugualmente agli orecchi sicché dopo un poco finivano con l'arrendersi al suo sortilegio. Col pretesto di guardare uscivano, andavano incontro a un tentacolo e ci cadevano dentro, diventavano anche loro un pugno chiuso, un volto distorto, una bocca contratta. Zì, zì, zì! E la piovra cresceva, si spandeva in sussulti, a ciascun sussulto altri mille, altri diecimila, altri centomila.
Un uomo, Oriana Fallaci.
Qualcosa di utile
Non ho mai avuto chiaro il senso della capienza dei bollitori elettrici: cosa dovrei fare con 1.7 litri d’acqua bollente? Un piatto di pasta e mezzo? Così mi sono molto affezionata al piccolo bollitore della Kenwood: basta e avanza per una tazza di tè e sta anche comodo sulla scrivania, praticamente indistruttibile.
Per il massimo della pigrizia tieni vicino anche una ciotolina di quelle per la salsa di soia, per esempio: quando il tè e pronto ci poggi la bustina bagnata e non devi nemmeno tornare in cucina al volo per buttarla.
Tre link
Ci interroghiamo spesso sull’opportunità o meno di pensare l’intelligenza artificiale in termini antropomorfi; mi sembra un’interessante riflessione parallela quella sull’antropodiniego fatta da
in più di una sua newsletter (quella sui topi e il primo soccorso, per esempio).La UX è come la dieta e l’esercizio: essenziale eppure così facilmente ignorata.
Jeanette Winterson ha un’opinione sui cui vale la pena soffermarsi riguardo l’intelligenza artificiale, che propone di chiamare intelligenza alternativa. Leggi OpenAI’s metafictional short story about grief is beautiful and moving.
In ascolto
Se usi Spotify puoi salvare la playlist.
Potresti voler leggere anche
Note
Io penso a una padellata in fronte, non so tu.

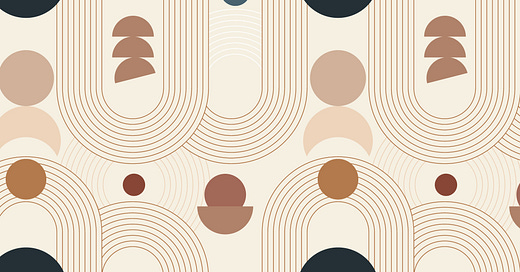


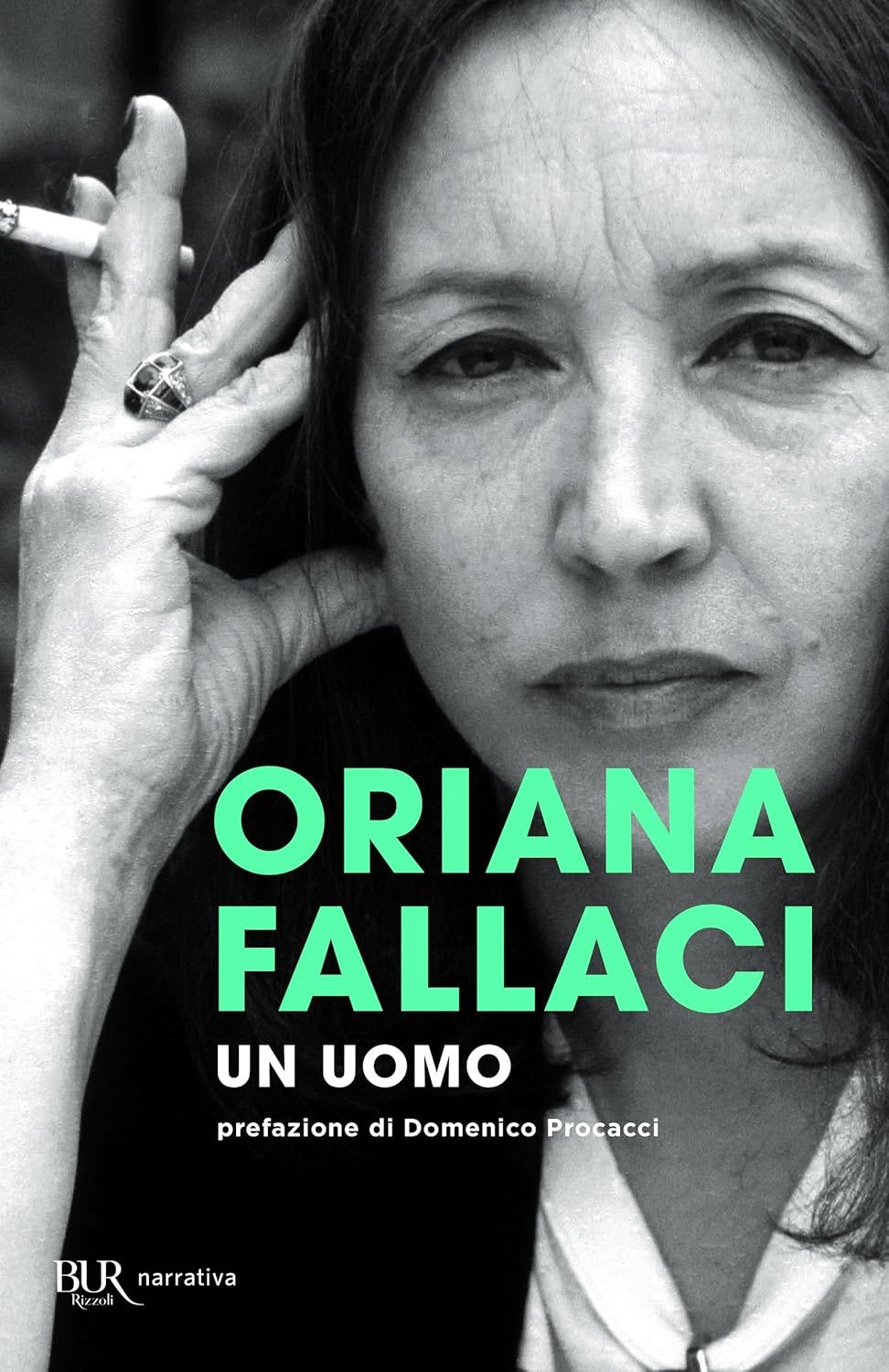



Che dire, una puntata che mi suona parecchio 😆.
Ho appena letto con un gruppo di lettura 8-10 anni un fumetto che è un inno alle onomatopee (oltre che divertentissimo): "HiLo. Il ragazzo precipitato sulla terra" di Judd Winick, primo di una serie di dieci volumi, di cui Il Barbagianni finora ne ha tradotti tre.
E mi fa piacere leggere di una convergenza di pensiero con Jeanette Winterson, visto che anch'io tempo fa avevo pensato proprio a 'intelligenza alternativa' come espressione più appropriata per l'intelligenza artificiale. Che poi, che cosa di umano non è artificiale?
"La fonosemantica apre la possibilità di una specie di grammatica sonora sull’utilizzo sapiente di vocali e consonanti che non può che essere di sicuro interesse per chi scrive": in questo libro bellissimissimo, Le parole dell'incanto, Franco Dogana spiega il fonosimbolismo alla perfezione. Lo consiglio per chi volesse approfondire!