Contro la creatività
La banalizzazione della creatività non solo svuota la parola di significato, ma agisce come un meccanismo culturale che neutralizza il potenziale dirompente della creatività autentica. Ma qual è?
Sarò finita dritta nel cestino, con questo titolo da guerrafondaia? Corro il rischio di risultare antipatica a diverse persone, ma sono una donna temeraria. Alcune cose, prima di iniziare.
Il 15 maggio a Milano sarò con
per Accessibility Days, dove terremo un workshop. Il programma della conferenza è online, la possibilità di iscriversi ai workshop è in arrivo.Lo scorso numero sulle lingue inventate sembra esservi piaciuto da matti (grazie, grazie). Sono fioccati da più parti consigli di lettura in aggiunta, e ho recuperato qualcosa di fondamentale che avevo dimenticato di menzionare: ho raccolto tutto nella sezione che in genere dedico ai link.
Oggi è l’ultimo giorno per abbonarsi ad Alternate Takes a un prezzo scontato. Nessuno ti vieta di abbonarti anche dopo (faccina ammiccante), ma magari preferisci approfittarne.
Sulle parole: quelle logorate
creatività s. f. [der. di creativo]. – Virtù creativa, capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia. In psicologia, il termine è stato assunto a indicare un processo di dinamica intellettuale che ha come fattori caratterizzanti: particolare sensibilità ai problemi, capacità di produrre idee, originalità nell’ideare, capacità di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze.
Quando abbiamo iniziato a pensare che la creatività sia l’equivalente di un hobby piacevole e l’abbiamo ridotta agli adesivi da attaccare su un quaderno colorato? A furia di usare un termine distorcendone il valore, finisce per svuotarsi del suo significato profondo. La creatività è diventata un accessorio luccicante ma innocuo della vita moderna, quasi un obbligo sociale per sentirsi realizzati, un distintivo da esibire per segnalare una presunta unicità, in un mondo percepito come standardizzato.
Creatività? Va detto che nello zoo dei concetti la creatività è uno degli esemplari più bizzarri e la sua gabbia pare dominio assoluto della legge dell’indeterminazione. Ora deserta, ora affollata delle creature più differenti nelle forme e variegate nelle livree e nei piumaggi. Designer, indiani metropolitani, pubblicitari, sarti, jazzisti, docenti di tecniche letterarie, funamboli, commercialisti, pedagoghi, bambini, artigiani, problem solver, cuochi, illusionisti... Tutti creativi. Metterci dentro anche le efficienti macchine di OpenAI non costa nulla, anche perché cosa sia davvero la creatività nessuno lo sa dire. I venditori di creatività scrivono manuali nella cui prima riga è scritto che mai si potrà definire la creatività, perché vendere quel che fa parte del genere merceologico del “un certo non so che” è molto gratificante, e non così faticoso. Cosa sia non si sa, però funziona, dicono loro. Non si sa cosa sia, aggiungiamo, ma alcune cose possono esserne dette.
Chi scrive è Stefano Bartezzaghi, che commenta su Doppiozero una notizia recente su alcune dichiarazioni di Sam Altman riguardo alcune nuove possibili “libertà creative” dell’intelligenza artificiale: ti consiglio di leggere il resto dell’articolo per completare il pensiero.
Chiarisco subito i miei intenti: è ovvio che non ho niente contro la creatività. Il “contro” è rivolto alla banalizzazione e all’equivoco dilagante che fa coincidere la creatività con passatempi piacevoli ma privi di impatto trasformativo, o peggio, con un’ispirazione quasi magica, un dono piovuto dal cielo che non richiede sforzo né disciplina, a cui basta spalancare le braccia per esserne pervasi.
Cosa non funziona
Ho l’impressione che questa idea diffusa di creatività, così focalizzata su attività accessibili a tutti e sull’espressione personale come fine ultimo, non sia tanto un reale apprezzamento della facoltà creativa, quanto una sorta di reazione difensiva alla complessità e all’incertezza in cui ci troviamo a vivere. Etichettare attività relativamente semplici come “creative” ci dà un immediato senso di controllo, di realizzazione personale e di distinzione individuale in un contesto sociale che può apparire alienante.
L’enfasi sulla creatività “facile” contrasta con la definizione della creatività come processo faticoso, che richiede impegno, metodo, disciplina e capacità di affrontare il fallimento – elementi che emergono chiaramente quando si analizza il concetto di insight e il lavoro strutturato necessario per coltivarlo. Promuoviamo una versione addomesticata della creatività perché è più rassicurante, più gestibile, meno perturbante.
L’inflazione del termine non rappresenta solo uno svuotamento di significato, ma agisce come un meccanismo culturale che neutralizza il potenziale dirompente della creatività autentica. La trasforma in un prodotto di consumo (hobby, corsi online, libri motivazionali) o in un’esperienza puramente individuale e terapeutica, scollegandola dalla sua funzione sociale cruciale: quella di risolvere problemi concreti, generare innovazione e contribuire al progresso collettivo. In questo modo, la creatività serve più a mantenere lo status quo che a sfidarlo realmente.
La narrazione dominante sulla creatività tende a ridurla a un catalogo di attività manuali, ricreative o legate al benessere personale: l’elenco delle applicazioni non ha limiti. Il fondamento condiviso sembra considerare queste applicazioni modi per “stimolare la fantasia” e “trasformare una passione in un progetto concreto e gratificante”. E certamente queste attività possono essere piacevoli, fonte di soddisfazione e persino terapeutiche; presentarle come l'essenza della creatività, però, oscura processi cognitivi ben più complessi e fondamentali per l’innovazione e la soluzione di problemi reali.
Pur riconoscendo i benefici che possono derivare da queste pratiche, relegare la creatività all’auto-espressione come scopo primario, la slega dalla sua dimensione abilità in grado di generare valore utile per una comunità. La creatività diventa così un affare privato, un percorso interiore, anzi che un motore di cambiamento esterno. Abbiamo esplorato così tanto la dimensione individuale che il mondo ci sta presentando il conto dell’aver trascurato troppo la dimensione comunitaria.
A complicare il quadro c’è il filone narrativo che ammanta la creatività di un’aura mistica o spirituale. La si descrive come un’energia esterna, una forza quasi magica che ci visita o ci sceglie, una “grande magia”, parafrasando il titolo di uno dei libri più popolari di questo filone1. Questo tipo di narrazione risulta seducente perché sembra democratizzare la creatività, rendendola accessibile a tutti. Rimuove le barriere percepite, come la presunta necessità di un talento innato o di lunghi studi specialistici. Questa democratizzazione avviene al prezzo di un appiattimento concettuale: spostando il focus dall’interno – il lavoro cognitivo, lo sviluppo di abilità, la disciplina – all'esterno – ricevere l'idea, ottenere il permesso, affrontare la paura del giudizio altrui – si riduce la responsabilità individuale nel costruire attivamente l'idea e la soluzione.
Non solo: crea aspettative irrealistiche. L’idea che la creatività debba essere sempre facile, gioiosa, spontanea e priva di sforzo porta inevitabilmente a frustrazione e abbandono di fronte alle difficoltà o all’assenza dell'ispirazione “magica”. Rende difficile riconoscere e valorizzare forme di creatività meno appariscenti, più legate al pensiero strategico, all'organizzazione o alla risoluzione di problemi complessi, che non rientrano nell'immaginario dell’hobby o dell’espressione artistica.
Questo approccio offre un messaggio confortante e inclusivo, elimina l’ansia da prestazione legata alla percezione di una mancanza di talento o preparazione, ma si tratta di un’accessibilità illusoria. Abbassando la soglia d’ingresso percepita si abbassa inevitabilmente anche il valore attribuito alla profondità e alla fatica del processo creativo autentico. La vera barriera alla creatività significativa, quella capace di generare innovazione e cambiamento, è la difficoltà intrinseca del pensiero profondo, della sintesi originale, della capacità di vedere connessioni inedite e della perseveranza necessaria per superare gli ostacoli e affinare il risultato.
Le narrazioni “magiche” offrono una scorciatoia emotiva che bypassa questa sfida cognitiva reale, proponendo un’illusione di creatività legata più all’atteggiamento mentale (coraggio, apertura, curiosità) che alla sostanza del lavoro intellettuale e pratico. Di conseguenza, paradossalmente, potrebbe persino scoraggiare l’impegno rigoroso necessario per raggiungere l’insight autentico, confondendo l’espressione personale, in cui non c’è niente di male, con la soluzione creativa a problemi concreti.
Insight?
In termini psicologici e cognitivi, l’insight è definito come la comprensione improvvisa e profonda di un problema, di una situazione o della soluzione a un enigma, spesso dopo un periodo di riflessione o incubazione. È il momento “Aha!” o “Eureka!”, quella sensazione quasi folgorante in cui i pezzi del puzzle sembrano andare improvvisamente al loro posto. Se hai mai visto la serie House M.D., una rappresentazione dell’insight è quel momento in cui House smette di parlare nel bel mezzo di un discorso, si gira, e senza dare spiegazioni se ne va alla svelta.
Nonostante sembri improvviso, l’insight non è un evento magico o inspiegabile, ma il risultato finale di specifici processi mentali. Si distingue dall’intuizione, che è spesso vista come un processo più graduale e basato sull’esperienza, proprio per la sua natura discontinua e inaspettata.
Il modello più classico e ancora accettato per descrivere il processo che porta all’insight è quello proposto da Graham Wallas nel suo libro The Art of Thought del 1926. Wallas identificò quattro fasi distinte, caratterizzate da un’alternanza tra lavoro conscio e processi inconsci.
Preparazione: è una fase interamente conscia e deliberata. Riguarda l’indagine approfondita del problema, la raccolta di informazioni, la ricerca, lo studio e l’accumulo delle risorse intellettuali necessarie. È il momento in cui si prepara il terreno mentale, si definisce il problema e ci si immerge completamente nel dominio di conoscenza pertinente. Richiede sforzo, attenzione focalizzata e pianificazione.
Incubazione: segue un periodo di elaborazione non conscia, durante il quale non si esercita uno sforzo diretto e focalizzato sul problema. La mente continua a lavorare in background: può avvenire mentre ci si dedica ad altre attività, anche non correlate, o durante il riposo e il sonno. L'importanza di lasciare che la mente vaghi o di dormirci sopra è cruciale per permettere l'emergere di nuove connessioni.
Illuminazione: è il momento culminante, l’emergere improvviso della soluzione o dell’idea chiave nella coscienza. Non sorge dal nulla, ma è il risultato del lavoro inconscio di ricombinazione e ristrutturazione degli elementi raccolti durante la preparazione e processati durante l’incubazione. È un momento di discontinuità rispetto ai tentativi precedenti.
Verifica: l’insight, per quanto potente, deve essere seguito da una fase conscia di valutazione critica, test, elaborazione, rifinitura e applicazione pratica. L’idea o la soluzione emersa deve essere messa alla prova, sviluppata nei dettagli e tradotta in un risultato concreto e comunicabile.
Le neuroscienze hanno iniziato a gettare luce sui meccanismi cerebrali sottostanti all’insight, confermando e arricchendo il modello di Wallas.
L’insight non è semplicemente un’idea brillante o originale fine a sé stessa. È la scoperta di una connessione nuova e – importantissimo – utile tra elementi preesistenti. Questa connessione porta a una soluzione originale ed efficace per un problema concreto, o apre una nuova prospettiva fertile. È proprio l'aspetto dell'utilità, intesa come soluzione di un problema, miglioramento di una situazione, produzione di qualcosa di buono riconosciuto da una comunità che distingue l’insight creativo dalla fantasia o dall’espressione puramente soggettiva. L’insigth non emerge dal vuoto, per magia: è la conclusione visibile di un processo in gran parte invisibile, ma che richiede input deliberati (la preparazione) e la creazione di condizioni favorevoli (l'incubazione, il distacco mentale).
La attenzione quasi esclusiva sul momento “Aha!”, sulla sua apparente immediatezza, unita alla narrazione magica di cui abbiamo parlato, oscura l’importanza cruciale e il carattere attivo delle fasi di preparazione e incubazione. Questo porta inevitabilmente a sottovalutare o svalutare il lavoro preliminare – lo studio, la ricerca, l’analisi approfondita del problema – e le strategie consapevoli per favorire l’incubazione – come fare pause, diversificare le attività mentali, permettere alla mente di vagare. Eppure, queste sono condizioni necessarie affinché l’insight possa emergere. La vera abilità creativa non consiste semplicemente nell’avere l’illuminazione, ma nel saper creare le condizioni perché essa possa manifestarsi, attraverso un lavoro preparatorio rigoroso e una gestione consapevole dell’intero processo cognitivo.
Non è un caso che la storia della scienza e della tecnologia sia costellata di esempi celebri che dimostrano il processo creativo basato sull’insight: scoperte rivoluzionarie emergono spesso da una combinazione di preparazione meticolosa, incubazione (talvolta inconscia o avvenuta in momenti di apparente distrazione), illuminazione improvvisa e successiva, rigorosa verifica.
Queste due visioni della creatività hanno implicazioni pratiche profonde su come noi, come individui e come società, investiamo il nostro tempo e le nostre risorse, su cosa scegliamo di valorizzare e insegnare, e sulla nostra capacità collettiva di affrontare le sfide complesse. Privilegiare la visione confortante, la narrazione magica e mistica, può portare a una gratificazione personale immediata ma rischia di distogliere energie dal lavoro profondo necessario per generare idee e soluzioni significative, con un valore collettivo duraturo.
Adottare consapevolmente una visione della creatività basata sull’insight e sul metodo implica riconoscere che la capacità di risolvere problemi complessi e generare vera innovazione richiede un approccio più impegnativo ma anche più fruttuoso a lungo termine. Promuovere questa visione permette di valorizza lo studio, la preparazione, la perseveranza e la verifica, e potrebbe essere fondamentale per coltivare le competenze necessarie ad affrontare il futuro. Sono contro la banalizzazione della creatività, perché preferisco un’idea che preserva e potenzia una delle capacità umane più preziose: quella di pensare in modo profondo e agire con efficacia per trasformare il mondo in meglio.
Vuoi lavorare con me?
Esercizi
Niente esercizi, godiamoci il ponte del 1 maggio. Se proprio non puoi farne a meno, leggi La trama lucente di Annamaria Testa: non è un caso se il suo blog si chiama proprio Nuovo e Utile. Se vuoi un assaggio, ascoltala parlare in questa intervista.
Un libro
E se una soluzione creativa fosse questione di vita o di morte? Quando in Il problema dei tre corpi scienziati e matematici si confrontano con un’intelligenza aliena che sfida le leggi fisiche conosciute, non si iscrivono a un workshop online a 99€ per sbloccare le idee. Elaborano una soluzione immersi nella necessità, stabilendo connessioni tra fisica, storia e filosofia che nessuno aveva mai colto prima. Liu Cixin mostra che la creatività nasce quando le vecchie mappe diventano inutili e bisogna tracciarne di nuove con gli strumenti che si hanno: conoscenza profonda, rigore analitico e la capacità di pensare l’impensabile.
Qualcosa di utile
È quasi il momento di mettere via il bollitore e preparare il te freddo. Tiro fuori dal mobile la caraffa da 2 litri che ci sta nello sportello del frigo, così per due o tre giorni sono a posto. In verità ogni tanto indulgo nel guilty pleasure di una bottigliazza di Estathé, ma non ditelo alla caraffa chic, che si offende. Permalosa.
Tre link
<sarcasmo>Il tempo di mare e vacanze si avvicina, vi consiglio una lettura su quel paradiso autentico e incontaminato che è la mia terra, la Sardegna, così ricca di tradizioni.</sarcasmo> Ne parla con esattezza
in Quella idea esotica di paradiso, condivido anche le virgole e i caratteri nascosti.How information architects are helping to build GOV.UK’s future
Anche in Italia si moltiplicano le persone convinte che usare la lineetta come segno di punteggiatura sia il marchio dell’intelligenza artificiale. Anche il Wahsington Post spiega che non è proprio così. Some people think AI writing has a tell — the em dash. Writers disagree.
Addendum: sulle lingue inventate
Codex Seraphinianus: dal 1981, anno della sua prima pubblicazione, il Codex Seraphinianus, enciclopedia visiva di un mondo sconosciuto scritta in una lingua sconosciuta, è diventato un oggetto di culto in tutto il mondo e ha affascinato una generazione di artisti, lettori e critici generando lunghi dibattiti sui suoi significati e sulla sua origine. Su YouTube potete ascoltare l’autore che ne parla.
Caterina Marrone è una filosofa che scrive in modo chiaro e avvincente (allora ne esistono!). Di suo devi leggere Le lingue utopiche, pubblicato dagli splendidi tipi di Scritture & Zabar.
Lingue oscure non è più disponibile nel catalogo Quodlibet, ma magari siete segugi dei libri usati. Parla di lingue intenzionalmente segrete, nate per confondere e occultare.
In ascolto
Se usi Spotify puoi salvare la playlist.



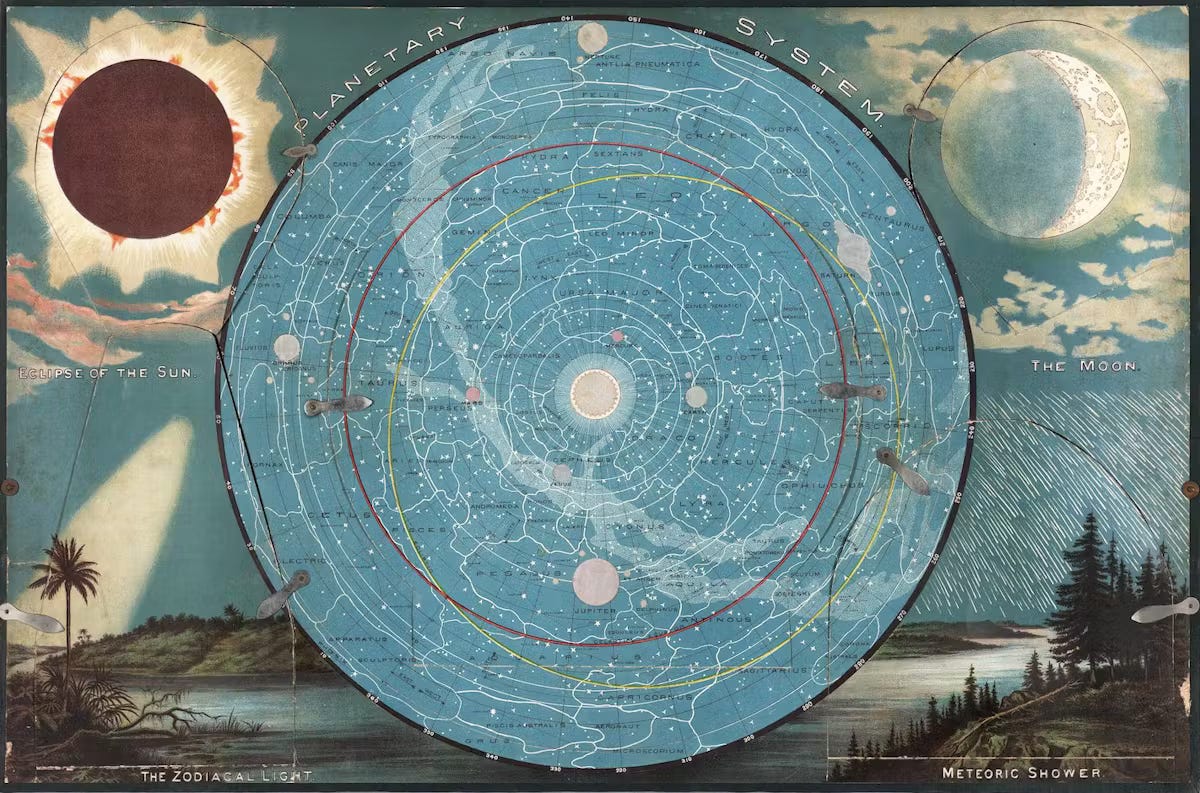
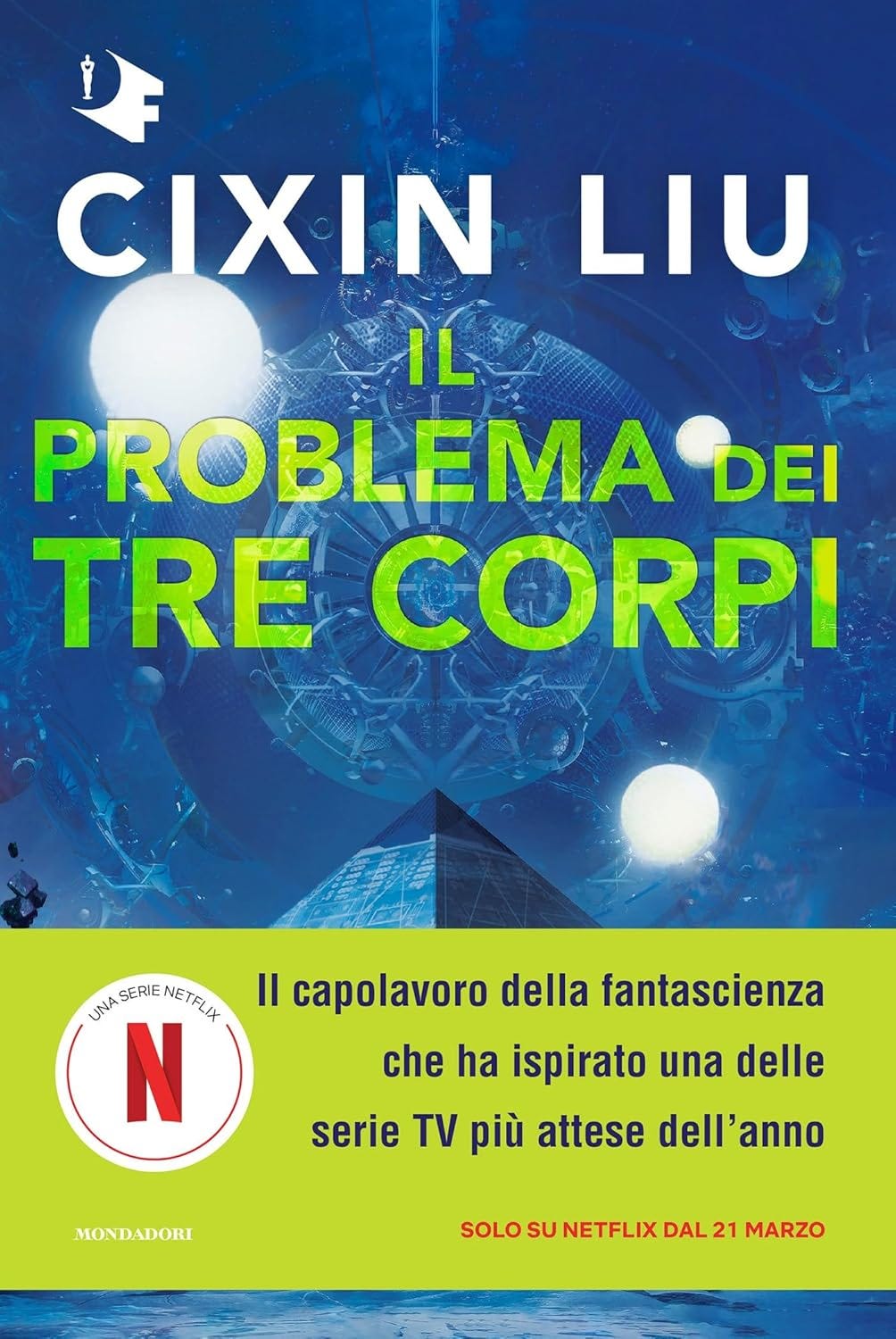



Recupero stamattina questo tuo episodio, proprio mentre lascio incubare l'idea per il numero di Ojalá di lunedì: sono indietro su tutto, oggi, ma leggerti mi ha magicamente (😬) messa di fronte a concetti che c'entrano molto con quello di cui vorrei scrivere. Come si chiama questo fenomeno? È creatività basata sull'insight anche trovare fili di connessione nelle parole altrui, proprio nel momento in cui servono? (Puoi anche rispondermi un sonoro NO.)