Leggere ad alta voce: intervista ad Alessia Canducci
«Le parole hanno un potere trasformativo incredibile, e la letteratura riesce a catapultarci in molteplici altrove che possono farci vibrare.»
“Leggere” è una serie di interviste dedicate alla lettura. Parlo con persone che leggono come parte del loro lavoro per conoscere le loro abitudini e tecniche. Arriva ogni prima domenica del mese ed è un ramo di Alternate Takes, la mia newsletter.
In questo appuntamento incontriamo Alessia Canducci: quando anni fa l’ho ascoltata leggere alcune pagine da Fai finta che io non ci sia, di Meg Rosoff, al festival Mare di Libri, ho capito che non era vero che non mi piacevano le letture ad alta voce. È che non ne avevo mai ascoltate fatte così bene.
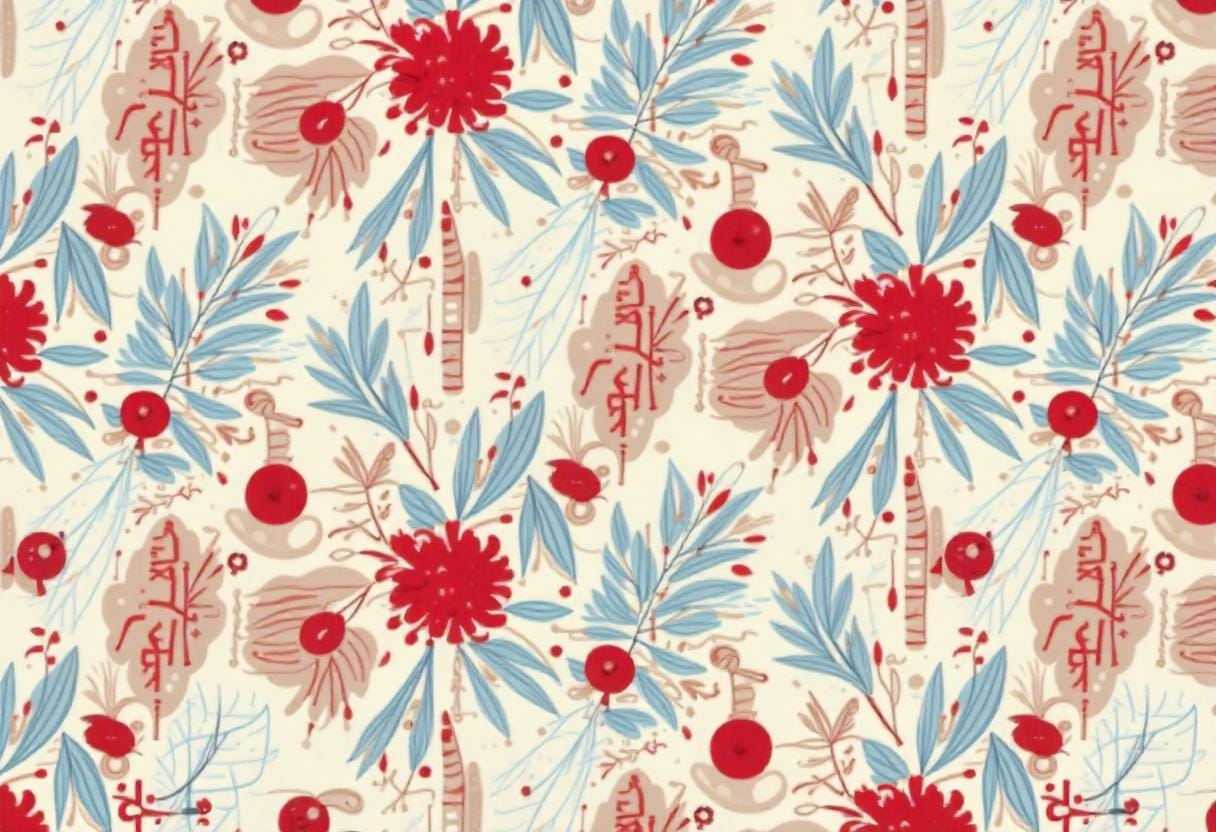
Ciao Alessia, mi racconti di te?
Mi definisco una attrice e regista “al servizio di libri e storie”. Leggo ad alta voce, narro, insegno da più di 30 anni, in particolare per bambini e ragazzi. Il mio lavoro è in continua evoluzione, mi dà tantissimo: porto le storie nei teatri, nelle biblioteche, nelle scuole, nei festival, al chiuso e all’aperto. La formazione teatrale e musicale, le esperienze e collaborazioni con colleghi e professionisti del settore che ho incontrato nei decenni hanno inevitabilmente plasmato il mio modo di lavorare attuale, quindi provo a raccontare a che punto sono ora.
Vivo nella splendida terra romagnola, in campagna vista mare, viaggio per lavoro e appena riesco anche con la mia famiglia. Amo leggere, e leggere ad alta voce, credo sia il mio dono, e la connessione che si crea con chi è con me è potentissima. Le parole hanno un potere trasformativo incredibile, e la letteratura riesce a catapultarci in molteplici altrove che possono farci vibrare. Si genera uno scambio emotivo che crea a volte come un rimescolo, e ci ricorda che quello scambio è unico, imprescindibile, ci rende vivi e non sostituibili.
È un rito collettivo che mi rende felice, ogni volta. Come leggere è importante, e va di pari passo con la scelta qualitativa di cosa leggere, che è connessa alle persone a cui si legge.
Il mio lavoro ha bisogno di vicinanza corporea, però dal 2020, durante i periodi di reclusione forzata da Covid mi sono resa conto che video e audioletture hanno comunque valore. Nel 2022 sono stata autrice e conduttrice di Tana Libera Libri, un format Tv tutto dedicato a libri e storie, per una rete di 30 tv private su territorio nazionale, coordinata da Icaro TV, in cui ho coinvolto colleghi che stimo: tutte le puntate sono fruibili online. Ho un canale Youtube su cui pubblico a cadenza piuttosto regolare contenuti poetici nella rubrica Versi persi-voce li dice; fiabe, narrativa e albi illustrati nella rubrica La Canducci Legge. Sono voce narrante di audiolibri per diverse case editrici. Amo l’umorismo, ma anche confrontarmi con temi che sento necessari: per 18 anni ho portato in teatri e scuole lo spettacolo ‘E per questo resisto’ voci e musiche in memoria della shoah con il gruppo rock dei Flexus, tratto dall’omonima antologia pubblicata da Equilibri; e da un anno porto in tournée Stardust, spettacolo sul cambiamento climatico insieme al musicista Federico Squassabia tratto dall’omonimo libro d’artista di Hannah Arnesen pubblicato da Orecchio Acerbo.
E poi c’è la formazione.
La mia ricerca è mettere gli strumenti del teatro al servizio della letteratura, e appassionare alla lettura, alla cultura adultə, bambinə, ragazzə. Mi muovo in una sorta di terra di confine che unisce cultura, istruzione e prevenzione al disagio. Sicuramente i venti anni di collaborazione con il programma nazionale Nati per Leggere hanno contribuito a questa domanda che mi accompagna: come rendere accessibile tutto questo (la letteratura) a chi non ne conosce l’esistenza? Credo che la lettura ad alta voce sia un mezzo per diffonderne bellezza e potenzialità.
Ma non certo l’unico. Collaboro con Biblioteche e istituti scolastici, enti pubblici e privati da tanti anni come “esperta esterna” in qualità di formatrice o narratrice e lettrice. Mi definirei una “attivatrice” di interesse e passioni, per ogni età. E la passione, se accesa, va tradotta in buone pratiche gestite da persone consapevoli, attente, in ascolto, attraverso percorsi educativi e servizi di qualità: scuole, biblioteche pubbliche, librerie specializzate capaci di dialogare sul territorio.
Potrei aggiungere che mi sento un tassello di un possibile disegno più ampio. Una delle ciliegine sulla torta, e la torta è composta dalla comunità educante.
L’ambiente di apprendimento è determinante per lo sviluppo di individui liberi e pensanti, e i bambini sono in totale balìa di noi adulti, che siamo troppo spesso inconsapevoli del nostro potere.
Lo so, mi sono dilungata, ma questo è uno dei motori delle mie scelte lavorative quotidiane: leggere per tutti e dedicare tempo alla formazione di adulti sul come leggere cosa ai bambini e ragazzi con cui lavorano. In questo ambito sono felice di collaborare anche con Alice Bigli, Francesca Mignemi, Roberta Favia, che si occupano di letteratura per ragazzi ed educazione alla lettura con competenza.
Quanto è importante la lettura nelle tue giornate?
Leggere è parte del mio quotidiano, corrisponde a un bisogno. Se preparo una formazione, rileggo o leggo saggi sul tema, mi aggiorno sulle novità o rileggo libri su cui scelgo di lavorare. Se preparo spettacoli, letture o percorsi, allo stesso modo, cerco brani significativi sull’argomento.
Se ho bisogno di ispirazione mi aggiro per le librerie di casa, o mi rifugio in biblioteche e librerie specializzate, chiedo a chi è più competente. E poi ci sono giorni in cui non leggo affatto, per far depositare ciò che ho letto.
Come scegli le tue letture? Quali criteri usi?
I libri che scelgo da leggere ad alta voce devono essere interessanti per me e capaci di creare sintonia ed interesse ai destinatari, permettere un rispecchiamento, non chiudere ma “aprire” alle domande. La domanda che mi guida è: che idea di infanzia o adolescenza è rappresentata? Il lettore è al centro? Amo le storie dotate di anima e corpo, intense, umoristiche ma non superficiali. Non amo affatto le storie “costruite”, in cui sia evidente una strategia tematica. La chiave è la scrittura, o la traduzione, nel caso in cui gli autori siano stranieri. È anche fondamentale che le parole suonino bene e che il linguaggio sia accurato, lo stile possibilmente ipotattico: ebbene si, ammetto di essere esterofila, soprattutto per quanto riguarda la narrativa per ragazzi.
Che tipo di testi leggi più spesso?
Se leggo per infanzia, adolescenza e famiglie amo portare con me molti più libri di quanti ne leggerò, e soprattutto una grande varietà di proposte: albi illustrati, narrativa, poesia, rime, silent books, graphic novels, fumetti, interattivi, divulgazione, fiabe. Lo faccio per agire un modello di possibilità; per suggerire, con la mia azione, che le possibilità di lettura sono molteplici, e il rito officiato in quel momento è una piccola parte del potenziale…
Ne porto in abbondanza anche perché non conosco i miei interlocutori, e mi tengo margini di variabilità in base a chi incontro, all’energia che si sviluppa.
All’interno di questa grande quantità in evidenza, se i destinatari sono bambini e famiglie leggo più spesso albi illustrati in cui entrambi si rispecchino in modelli positivi, ironici, senza risposte ma con molte domande… non rinuncio alla poesia, o ai libri senza parole, a qualche piccolo racconto senza illustrazioni. Ho sempre con me anche i Silent books, strumenti potenti per accorciare le distanze linguistiche e realzionali. Se i destinatari sono adolescenti o adulti, do maggiore spazio alla narrativa e alla poesia, sempre cercando di mettermi in ascolto di chi ho di fronte.
Hai un metodo di lettura specifico legato alla tua professione?
Solo questa risposta meriterebbe un paio di ore… leggere ad alta voce riguarda il corpo intero, e la relazione che riusciamo a mettere in gioco con noi stessi, la storia che leggiamo, le persone con cui siamo. Riguarda la mimica, il gesto, le emozioni e soprattutto l’ascolto che riusciamo a sviluppare. Non ho un metodo, no, diciamo che cerco di sintonizzarmi con il contesto, senza maschere, cercando di essere disponibile alle trasformazioni che lo scambio genera.
A livello tecnico, nei decenni si è molto sviluppato il “colpo d’occhio”. Per la narrativa mi capita sempre più di entrare tra le righe del testo, e sentirlo, cogliere i passaggi emotivi, e dare spazio a quelli, a tutto ciò che va oltre le parole. Per albi, silent e graphic novel leggo la relazione tra i linguaggi che compongono la storia, e la parola che mi guida è “complessità”.
Su che strumenti leggi in genere? Perché li preferisci?
Sono analogica, e ho bisogno del libro come oggetto, sia quando leggo per me, sia e soprattutto quando leggo ad alta voce: la voce è la punta dell’iceberg-corpo.
Ecco che nella lettura di albi illustrati, a seconda del formato che hanno, è fondamentale la loro gestione in quanto oggetti progettati per una certa fruizione. Come li tengo in mano, come giro la pagina, con che ritmo li apro, li chiudo e li leggo è determinante per guidare l’ascolto e lo sguardo di chi è presente. Ci sono situazioni in cui devo anche utilizzare immagini proiettate. Ammetto di soffrirne un poco… Se leggo narrativa o poesia, preferisco comunque tenere il libro in mano, diventa il prolungamento del mio corpo. Nei casi sopracitati amplifico la voce con un microfono ad archetto, che porto sempre con me. In alcuni spettacoli o reading, soprattutto per il pubblico adulto utilizzo il leggio e microfono gelato, e in quel caso, anche l’immobilità del corpo è una scelta espressiva.
Ma i libri devono esserci come oggetto, sempre, perché il mio sogno è che al termine del rito collettivo è che i presenti desiderino possedere proprio quei libri per continuare a leggerli, o rileggerli…
Le tue abitudini di lettura sono cambiate nel tempo? Quali sono stati i cambiamenti più significativi?
La lettura ad alta voce è il centro del mio lavoro, e si nutre della lettura autonoma. Però sempre più spesso mi capita, quando trovo un passaggio per me significativo, di avere bisogno di condividerlo ad alta voce! A volte ho la sensazione che potrei leggere per ore ad altri, è in quello scambio emotivo che si genera umanità e trasformazione. Nella quotidianità ci sono periodi di lavoro intenso in cui leggere è davvero difficile e frammentario, e credo che anche l’uso dei social per lavoro contribuisca a questa frammentazione.
Organizzi in qualche modo il tempo che dedichi alla lettura?
Macchè, ci provo, ma con scarsissimi risultati. Diciamo che cerco di tenere in agenda dei momenti dedicati. Quando sono a casa e preparo lavori e progetti, vivendo in campagna e avendo una figlia non ancora maggiorenne, come estremo salvatempo… mi porto i libri in borsa e sfrutto i tempi morti quando sono in giro nel mio ruolo di madre-taxi. Se sono in trasferta in auto i libri da leggere languono in una o più borse nella speranza di un varco spazio-temporale libero, e se viaggio in treno… beh va meglio, sì.
Come decidi quali parti di un testo meritano una lettura approfondita e quali una lettura più veloce?
Il colpo d’occhio è fondamentale, ma anche il passaparola! Ciò che leggo è già il frutto di una precedente indagine e scelta, grazie ai consigli di persone competenti che stimo. Dipende da cosa cerco. Se “cerco” dei passaggi significativi per stile o per tema, cambia il parametro di ricerca. Mi sintonizzo e se trovo un brano che risuona, mi ci tuffo.
Ci sono differenze tra il tuo modo di leggere per lavoro o per piacere? Ci sono casi in cui si influenzano a vicenda?
Amo molto la letteratura per ragazzi anche nel tempo libero. Però diciamo pure che nei mesi di lavoro più itinerante e concitato mi concedo solo letture di saggi, e scelgo di non abbandonarmi ai romanzi, perché mi metterebbero “nei guai”. Mi spiego meglio: quando leggo per me, se ciò che leggo mi cattura, mi accompagna per giorni nella mente e mi genera stati emotivi che condizionano le azioni nel quotidiano, finchè non finisco il libro sono trasognata e altrove. E siccome il mio lavoro richiede una presenza mentale ed emotiva ad alta performatività… non posso e non voglio essere altrove. L’altrove me lo concedo soprattutto in estate, quando i ritmi si dilatano, e nelle vacanze.
Come ti comporti quando devi affrontare una grande quantità di materiale da leggere?
Come risposta “vado in panico” è contemplata? Scherzi a parte, ci sono periodi dell’anno in cui i ritmi lavorativi mi permettono di studiare e prepararmi senza notti insonni; in quel caso parto dall’organizzazione… degli spazi. Essendo io analogica e intuitiva preferisco avere i libri cartacei; spesso il materiale da leggere è allo schermo del computer, e questo mi permette un approccio più strutturato. In entrambi i casi, mi tuffo nei materiali, studio e aspetto che l’intuizione e il mestiere facciano il resto.
Prendi appunti mentre leggi? Usi strategie o tecniche per organizzare, memorizzare e ritrovare le informazioni importanti?
Sono terribile, assolutamente istintiva e fisica, riempio il libro di appunti in matita, post it, orecchie, se è di mia proprietà. Se è della biblioteca… cerco di essere più attenta.
Non ho strategie, ma più o meno negli anni continua ad accadere questo: la prima fase è di ispirazione o di prima lettura; quando cerco contenuti per percorsi che sto preparando ho bisogno di fare ordine nella mia libreria e cercare fisicamente i libri, (o vado in biblioteca e libreria specializzata) poi mi ci siedo in mezzo, a terra, nel mio studio oppure, se il clima lo permette, in giardino, e vago, leggendo. Allora nella mente si creano connessioni, libere associazioni, e le fisso prendendo appunti a penna sul “quaderno-delle-idee-di-lettura”. Questa fase può durare più giorni, ed è di accumulo creativo, che mi distrae anche nel quotidiano, di continuo. E ogni interruzione (e vi assicuro che ce ne sono moltissime, emergenze burocratiche, progettuali, famigliari…) provo proprio una irritazione profonda e ho come mezzo cervello intorpidito. Quando sento che sono a buon punto passo al file nel computer, e inizio a scegliere e fare ordine, (e sono meno intrattabile).
Raccontami di due libri: quello che hai sul comodino e quello che consigli a tutti di leggere.
Sul comodino si mescolano libri “per me” e libri di lavoro; al momento convivono alcuni romanzi Young Adult per un reading che sto preparando per il festival Mare di Libri (che amo e con cui collaboro da quando è nato, 28 anni fa), insieme a due saggi: I guardiani della memoria di Valentina Pisanty sul ritorno delle destre xenofobe, che sto iniziando a leggere e uno di Gaia Vince Il secolo nomade sul cambiamento climatico che ho finito di leggere. Sempre però ho con me la raccolta di poesie La gioia di scrivere della gigantesca Wislawa Szymborska. C’è la vita tutta, lì dentro. Unico rammarico non conoscere il polacco, e poterle leggere solo tradotte. Tra questi… ne consiglio due: la Szymborska per l’anima, e Il secolo nomade per cambiare prospettiva sul nostro esistere su questa terra.
Era una bella intervista? Condividila: lo apprezzo molto!







https://www.feltrinellieditore.it/opera/una-storia-della-lettura/
Alberto Manguel racconta come la lettura fosse un'attività che si faceva ad alta voce e come e quando si è passati alla lettura da soli in silenzio. È un libro meraviglioso. Buona lettura!
Che bello leggere il racconto di Alessia Canducci. Ho potuto conoscerla due anni fa, quando fu ospite per Filò festival in Valtrompia: ricordo che feci una formazione di tre ore con lei e imparai altre cose sulla lettura ad alta voce, che ancora conservo e uso nella mia parte di mestiere da lettore. E la cosa sorprendente è che si impara continuamente, a ogni incontro.
Come sempre grazie Letizia per questi approfondimenti!